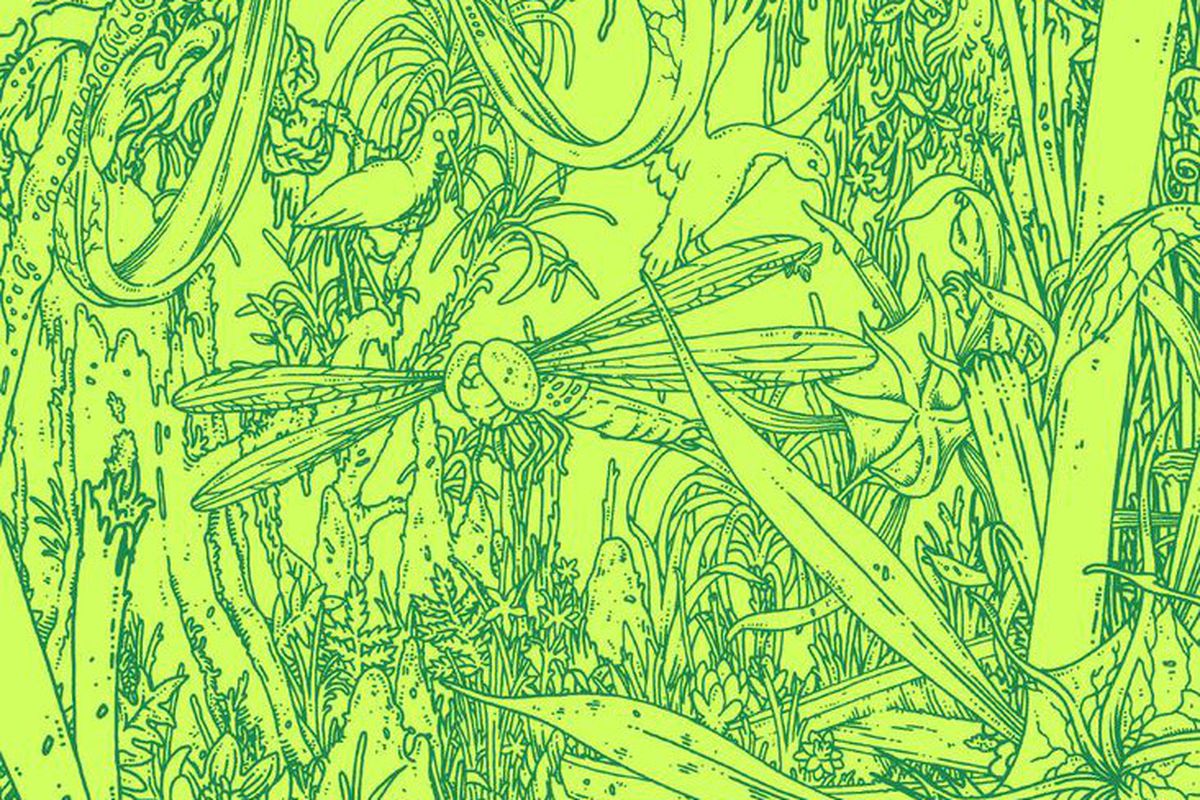Stoner, John Williams
William Stoner si iscrisse all’Università del Missouri nel 1910, all’età di diciannove anni. Otto anni dopo, al culmine della prima guerra mondiale, gli fu conferito il dottorato in Filosofia e ottenne un incarico presso la stessa università, dove restò a insegnare fino alla sua morte, nel 1956. Non superò mai il grado di ricercatore, e pochi studenti, dopo aver frequentato i suoi corsi, serbarono di lui un ricordo nitido. Quando morì, i colleghi donarono alla biblioteca dell’università un manoscritto medievale, in segno di ricordo. Il manoscritto si trova ancora oggi nella sezione dei “Libri rari”, con la dedica: “Donato alla Biblioteca dell’università del Missouri in memoria di William Stoner, dipartimento di Inglese. I suoi colleghi.”
Può capitare che qualche studente, imbattendosi nel suo nome, si chieda indolente chi fosse, ma di rado la curiosità si spinge oltre la semplice domanda occasionale. I colleghi di Stoner, che da vivo non l’avevano mai stimato gran che, oggi ne parlano raramente; per i più vecchi il suo nome è monito della fine che li attende tutti, per i più giovani è soltanto un suono, che non evoca alcun passato o identità particolare cui associare loro stessi o le loro carriere.
Con queste righe lapidarie si apre Stoner, il terzo dei quattro romanzi pubblicati da John Williams. E leggendo questo incipit è automatico chiedersi come possa una storia presentata in modo così piatto coinvolgere il lettore, ma basta procedere con la lettura di qualche pagina per lasciarsi inspiegabilmente trasportare con delicatezza fino alla sua straziante conclusione.
William Stoner è ciò che potremmo definire un uomo comune, un everyman dal sapore joyciano, che in seguito a una epifania letteraria decide di intraprendere la carriera di insegnante universitario. Stoner, come tanti altri, si distacca presto dai genitori contadini, si sposa giovane, non presta servizio durante le due guerre mondiali e conduce una vita banale, costantemente umiliato da una moglie che lo reputa essere la causa della primaria della propria infelicità e da un ambiente lavorativo ostile, competitivo e vendicativo. Eppure Stoner resiste, esistendo passivamente giorno dopo giorno, costruendosi una corazza di dolorosa indifferenza, ancorato al ricordo di un vecchio amico morto in guerra e al nostalgico pensiero della figlia Grace, imprigionata come lui in una vita che non riesce – o forse non vuole – cambiare e da una riluttante inerzia.
Quando rinuncia ad arruolarsi come invece scelgono di fare tanti suoi colleghi, Stoner pare trarsi in salvo dalla morte certa che lo aspetta in battaglia, eppure egli perisce tanto quanto il migliore amico Dave Masters, caduto sul campo, con la differenza che l’agonia di Stoner viene prolungata per tutta la sua esistenza, non è immediata né liberatoria come quella di Dave. Intrappolato dalla sua stessa mediocrità e indolenza, Stoner galleggia tra abusi e soprusi ai quali raramente – e sempre in modo superficiale – decide di opporsi, proprio come il suo stesso cognome sembra suggerire: stone, pietra immobile e inerte, ma anche stoner come qualcuno che si è “stonato” con una droga, che si osserva dal di fuori mentre fluttua nell’etere.
Ciononostante è possibile rintracciare in William Stoner un qualcosa di estremamente eroico, in quanto egli è in grado di resistere e sopravvivere alla vita grazia a una stoica rassegnazione volta all’attesa inerte della morte; Stoner è un eroe perché riesce a fare quello che pochi di noi riescono a fare: accettare la propria ineluttabile infelicità con lucido coraggio.
Ponderatamente, con calma, realizzò che doveva sembrare un vero fallimento. Aveva voluto l’amicizia, e quell’intimità legata all’amicizia che potesse renderlo degno del genere umano. Aveva avuto due amici, e uno dei due era morto insensatamente prima che potesse conoscerlo, mentre l’altro si era ormai ritratto a tal punto tra i vivi, che…
Aveva voluto l’unicità e la quieta indissolubilità del matrimonio. Aveva avuto anche quella e non aveva saputo che farsene, tanto che si era spenta. Aveva voluto l’amore e ci aveva rinunciato, abbandonandolo al caos delle possibilità.
Aveva voluto essere un insegnante e lo era diventato. Eppure sapeva, lo aveva sempre saputo, che per buona parte della sua vita era stato un insegnante mediocre.
Aveva sognato di mantenere una specie di integrità, una sorta di purezza incontaminata; aveva trovato il compromesso e la forza dirompente della superficialità. Aveva concepito la saggezza e al termine di quei lunghi anni aveva trovato l’ignoranza. E che altro?, pensò. Che altro?
Cosa ti aspettavi?, si domandò.
Una vita, quella di Stoner, che pare sembrare sotto tutti gli aspetti insignificante, ma che si rivela essere appassionante e straziante nella sua semplicità, portandoci presto a solidarizzare con il dramma dell’impotenza del protagonista.
Provava insieme orgoglio e vergogna, e soprattutto un amaro senso di delusione, verso se stesso e verso il tempo e le circostanze che rendevano la sua esistenza possibile.
La soluzione pare essere una sola: alienarsi in un nichilismo arreso che diventa voce dello statunitense piccolo borghese medio, la cui frustrazione sfocia talvolta in depressione, talvolta in piccole manifestazioni di alcolismo quando la patina del matrimonio perfetto, della famiglia perfetta e della lavatrice perfetta si smembra nella disperazione più cupa, come sottolinea molto bene questo passaggio:
Parlarono fino a notte fonda, come vecchi amici. E Stoner alla fine capì che Grace, come gli aveva detto, era quasi felice nella sua disperazione. Avrebbe vissuto serenamente, bevendo sempre un po’ di più, anno dopo anno, per stordirsi e non pensare al nulla cui si era ridotta la sua vita. Fu lieto che avesse almeno quello, fu grato che potesse bere.
Nonostante la tetra conclusione dell’esistenza di Stoner e della sua famiglia, credo che questo bellissimo romanzo ingiustamente poco letto covi in seno un potente messaggio di ottimismo, uno stimolo a non farci attraversare passivamente dagli eventi ma a reagire, a cercare la felicità anche quando tutto sembra essere perduto. Fraternizziamo con Stoner e allo stesso tempo abbiamo paura di lui, perché il disprezzo che la sua inettitudine stimola è forse lo stesso che proviamo verso noi stessi in determinate fasi della nostra vita. L’esortazione finale, quindi, è proprio quella di non diventare come Stoner. Ammesso e concesso che non lo siamo già diventati.